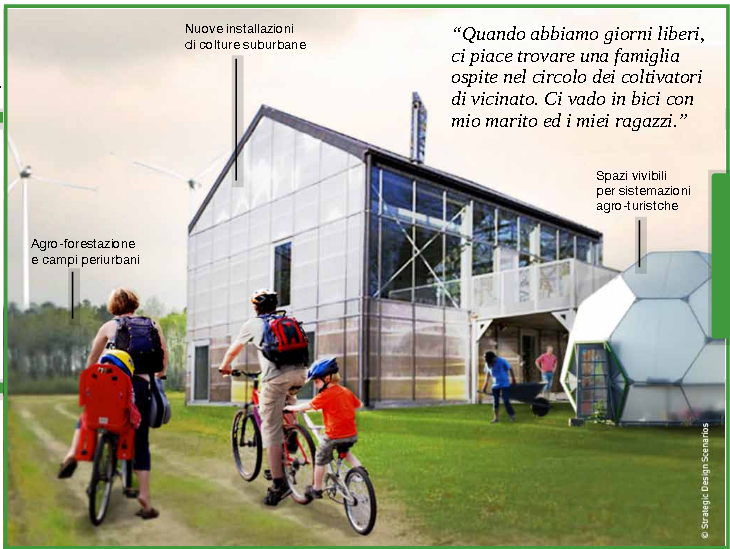Spesso, come stamattina, scelgo dove recarmi in escursione consultando la “chiarezza”, che potremmo definire come la connessione di tutte le cose – per accedervi occorre solo rilassarsi consapevolmente, rimanendo presenti alle sensazioni che si provano nell’istante presente. Sicché, stamane, prima dell’alba, sebbene mentalmente volessi andare in tutt’altro posto, la chiarezza mi suggeriva invece di andare altrove, cosa che naturalmente ho fatto.
In questi casi, infatti, mi diverto molto pensando a quale mai possa essere l’appuntamento misterioso verso cui sto andando, quello che attrae i miei passi e respiri, mentre attraverso le aree naturali che di volta in volta mi ospitano ed ispirano.
Così, in passato, mi è capitato di incontrare aquile e lupi – decisamente incontri inusuali nel civilizzato Salento; certo, come in tutte le cose, occorre anche sapersi comportare, simili incontri capitano a chi segue quanto scriveva John Muir nella seconda metà del 1800 “Solo andando da soli, in silenzio, senza bagagli, si può veramente entrare nel cuore della natura selvaggia.“
E non solo, nell’andare, bisogna essere rispettosi, occorre sapersi fermare spesso, per ascoltare ed apprezzare: anche un bruco che mangia una foglia si sente distintamente, quando siamo nel cuore delle aree naturali, lontani dai suoni della civiltà dell’industria e del consumo.
Sicché oggi, mentre ammiravo il sole attraversare le foglie di una densa copertura di lecci, ho sentito in lontananza il suono di passi sulle foglie secche, che si avvicinavano trotterellando.
Già avevo notato delle fatte (la popò) inusuali, diverse da quelle delle volpi, che vengono messe in bella mostra per segnare il territorio, queste erano più grosse e seminascoste tra le foglie cadute, chi mai poteva averle lasciate?
Mentre i passi si avvicinavano, rivelando con la loro intensità un animale di una certa dimensione, stavo già preparando la macchina fotografica, spostando la sensibilità ad iso 800, per via della poca luce che attraversa il fitto del bosco, aspettandomi di vedere presto uscire dalla vegetazione la familiare figura di una volpe, come in tanti altri buffi incontri avuti altre volte.
Ma … no, d’un tratto un orecchio bianco e nero mi paralizza dallo stupore, incredulo – un solo abitante del bosco ha questi colori così netti, possibile mai un incontro del genere durante il giorno?
Ed eccolo qui, trotterellare verso di me, fino ad arrivare a pochi metri dai miei piedi e fermarsi anche lui incuriosito: un bellissimo tasso, nel pieno del suo splendore e vigore di giovane adulto, ricoperto da una fitta pelliccia brizzolata ad annusare l’aria alzandosi sulle sue larghe zampe da orsetto (i tassi, come gli orsi, sono plantigradi, ossia poggiano l’intero piede a terra, tallone compreso).

Rido dentro di me, pensando alla sua vista ancor più debole della mia – da buon animale notturno il suo è un mondo fatto di odori e rumori e un essere umano silenzioso, che usa solo sapone di Marsiglia per lavarsi e sbarbarsi, senza nessun tipo di profumi aggiunti, deve essere per lui un ossimoro, la qual cosa mi lascia tempo per fotografarlo e poi addirittura filmarlo, prima che possa decidere per un dietro-front.
A me rimane la sensazione di un incontro importante, di un’altra creatura che non ha la parola ma chiede di essere rappresentata da qualcuno che ne difenda il diritto ad esistere, come anche il diritto delle nuove generazioni ad avere la possibilità, un giorno, di fare incontri come questo.
Ed è questa la ragione per cui è importante utilizzare piattaforme di citizen science per registrare le nostre osservazioni nella natura – recentemente, utilizzando osservazioni come questa, pubblicate su iNaturalist e quindi confluite nel GBIF (Global Biodiversity Information Facility), è stato possibile caratterizzare per ricchezza in biodiversità gli elementi della rete ecologica di Leverano, un passo importante confluito nel processo di pianificazione territoriale per il nuovo Piano Urbanistico di Leverano, per far sì che la natura d’Arneo abbia un futuro.




 Biodiversità
Biodiversità  Mobilità sostenibile
Mobilità sostenibile Sviluppo edilizio
Sviluppo edilizio  Rifiuti
Rifiuti Inquinamento
Inquinamento  Verde urbano.
Verde urbano.